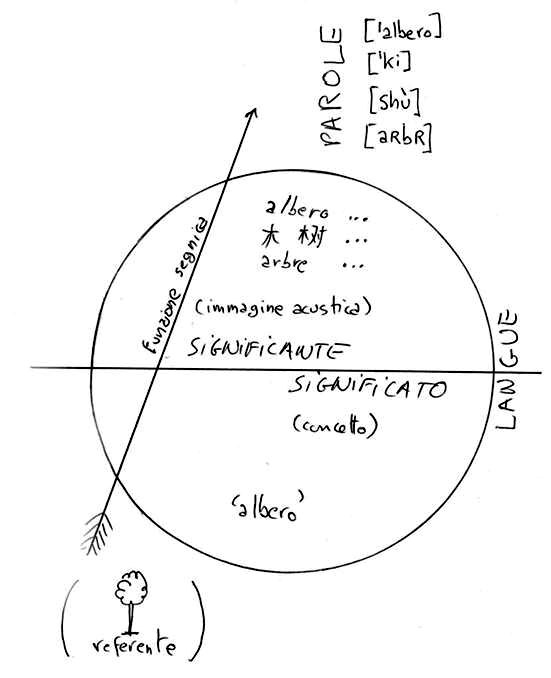
[tav. 1]
Schema del segno per Saussurre. Basato sul modello proposto nel Cours.
di Manuel Barbera (b.manuel@inrete.it).
Molti dei concetti basilari su cui si fonda la moderna linguistica
teorica risalgono alle lezioni di linguistica generale che Ferdinand de Saussure
tenne a Ginevra negli anni 1908-1909 e 1910-1911. Gli appunti di quei corsi, riordinati
e pubblicati postumi dagli allievi Charles Bailly e Albert Séchehaye nel 1916
col titolo di Cours de linguistique générale, sono stati di importanza fondamentale
per la linguistica moderna, oltre che per la semiotica, come abbiamo detto.
Segnalo, tra l'altro, che, una volta tanto, il migliore commento al Cours è,
per nostra fortuna, in italiano (ed è stato tradotto in francese!), opera di
Tullio De Mauro: cfr. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale,
publié par Charles Bailly et Albert Séchehaye, avec la collaboration de Albert
Riedingler, édition critique préparée par Tullio de Mauro, postface de Louis-Jean
Calvet, Paris, Payot, 2001(rist.) [1995(3), 1972(1)] "Grande bibliothèque Payot".
Edizione originaria: ibidem, 1916. Edizione italiana: Corso di linguistica
generale, introduzione traduzione e commento di Tullio De Mauro, Roma - Bari,
Laterza, 1967(1).
Per presentare quali siano le caratteristiche generali più importanti del linguaggio umano, pertanto, inizieremo proprio da quelle individuate e descritte dal geniale pensatore ginevrino.
Avevamo accennato come il particolare "simbolo" (messaggio codificato)
che viene scambiato in quella specifica forma di comunicazione che è
il "linguaggio umano" (cfr. tav. 1.1-1)
sia un "segno linguistico". Quali sono allora le sue caratteristiche?
Iniziamo col disegnarne uno schema:
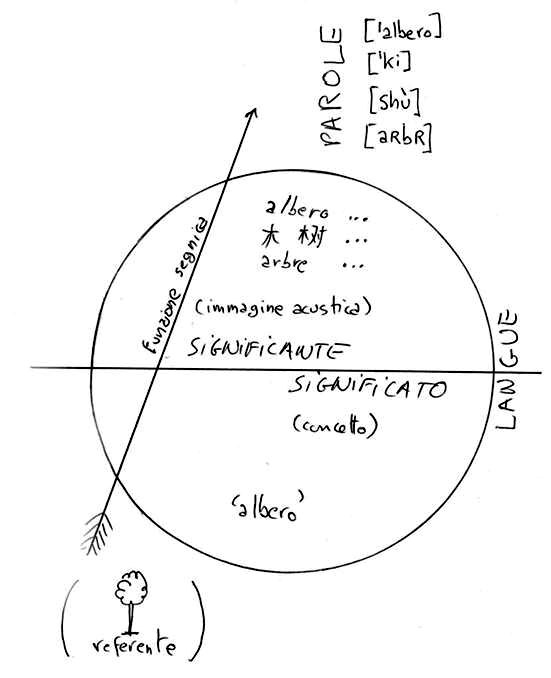
[tav. 1]
Schema del segno per Saussurre. Basato sul modello proposto nel Cours.
Saussure chiamava le due facce del segno signifié
'significato' e signifiant 'significante'
(due termini che sono rimasti poi standard nella tradizione linguistica e semiotica),
precisando che il segno linguistico è una «entité psychique à deux faces» che «unit
non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique» (Cours,
pp. 98-99).
La natura completamente "astratta" del segno linguistico è,
in effetti, una delle grandi conquiste del pensiero di Saussure. "Astratto", però,
può volere dire molte cose (già solo in linguistica vedremo tra poco come la tradizione
generativa ne faccia uso non del tutto identico); in Saussure è usato nel senso di
psychique, 'mentale' diremmo oggi, in quanto opposto a matériel, 'materiale'
nel senso di fisico, oggettuale: né il segno
stesso è un oggetto del mondo, né lo è il suo "significato", che è invece un concetto,
quindi ancora una volta una realtà astratta, "mentale", né lo è il suo "significante",
ché è invece una "immagine acustica", non una fisica e concreta onda sonora.
Proviamo infatti a pensare a cosa accadrebbe se le unità del nostro
linguaggio invece di essere "segni" fossero "cose": è proprio quello che satiricamente
Jonathan Swift (1667-1745), nei suoi Gulliver's Travels (l'
e-text
è scaricabile liberamente dal Project Gutemberg), faceva proporre agli
improbabili "dotti" della ancor più improbabile Accademia delle Scienze di Lagado:
We next went to the school of languages, where three professors
sat in consultation upon improving that of their own country.
The first project was, to shorten discourse, by cutting polysyllables into one,
and leaving out verbs and participles, because, in reality, all things imaginable are but
nouns.
The other project was, a scheme for entirely abolishing all words whatsoever; and this
was urged as a great advantage in point of health, as well as brevity. For it is plain,
that every word we speak is, in some degree, a diminution of our lunge by corrosion,
and, consequently, contributes to the shortening of our lives. An expedient was therefore
offered, "that since words are only names for things, it would be more convenient for
all men to carry about them such things as were necessary to express a particular business
they are to discourse on." And this invention would certainly have taken place, to the
great ease as well as health of the subject, if the women, in conjunction with
the vulgar and illiterate, had not threatened to raise a rebellion unless they might
be allowed the liberty to speak with their tongues, after the manner of their forefathers;
such constant irreconcilable enemies to science are the common people.
However, many of the most learned and wise adhere to the new scheme of expressing
themselves by things; which has only this inconvenience attending it, that if a man's
business be very great, and of various kinds, he must be obliged, in proportion,
to carry a greater bundle of things upon his back, unless he can afford one or two
strong servants to attend him. I have often beheld two of those sages almost sinking
under the weight of their packs, like pedlars among us, who, when they met in the
street, would lay down their loads, open their sacks, and hold conversation for an
hour together; then put up their implements, help each other to resume their burdens,
and take their leave.
But for short conversations, a man may carry implements in his pockets, and under his
arms, enough to supply him; and in his house, he cannot be at a loss. Therefore the
room where company meet who practise this art, is full of all things, ready at hand,
requisite to furnish matter for this kind of artificial converse.
Another great advantage proposed by this invention was, that it would serve as a
universal language, to be understood in all civilised nations, whose goods and utensils
are generally of the same kind, or nearly resembling, so that their uses might easily
be comprehended. And thus ambassadors would be qualified to treat with foreign princes,
or ministers of state, to whose tongues they were utter strangers.
[tav. 2]. Le proposte paradossali dei dotti dell'Accademia di Lagado sul linguaggio: (a) ridurre la la lingua alla nomenclatura, (b) ridurre i nomi agli oggetti.
Il segno linguistico, pertanto, è una struttura astratta, distinta dai
concreti atti linguistici. Saussure esplicitava questa alterità radicale introducendo
l'opposizione tra langue e parole (notate che è consuetudine dei
linguisti mantenere questi due termini sempre in francese), ossia tra una struttura,
una grammatica, astratta, arbitraria e convenzionale (cfr. il paragrafo sg.), ed una
produzione, un atto linguistico, concreto, materiale e contingente.
Il fatto (per esplicitare l'esempio usato nella tav. 2) che noi abbiamo
di 'albero' (è uso comune indicare la trascrizione semantica, ossia – per dirla alla
buona – il significato dei concetti, con gli 'apici semplici') il concetto che ne
abbiamo e che lo esprimiamo con l'immagine acustica
albero è un fatto della "langue", ossia di quella precisa struttura-lingua
che è la "grammatica italiana", la cui natura propria è astratta (tanto mentale quanto sociale,
come vedremo meglio tra poco), mentre la nostra effettiva, concreta, produzione fonica
['albero] (la indico con le convenzioni della trascrizione fonetica - tra quadre
ed in IPA - che studieremo in sèguito) è un atto di "parole", ossia un fatto
contingente del mondo.
Il modo tipicamente saussuriano di opporre piano astratto (mentale)
e piano concreto (materiale) si comprende meglio considerando altre due fondamentali
caratteristiche, tra loro strettamente legate, del segno
linguistico e della "langue": la loro arbitrarietà e convenzionalità.
Queste prerogative, che risalgono, nella "soluzione" al
De interpretatione
di Aristotele (che avevamo già iniziato a leggere e cui vi invito ora a ritornare),
e nella "impostazione del problema" al
Cratilo di Platone (cui arriveremo fra poco).
La distinzione dei due
concetti, inoltre, anche era già chiara nel Cratilo,
si era persa nella tradizione successiva ed è merito di Saussure averla ribadita.
Arbitrarietà e convenzionalità sono generali ed investono tanto il segno nel suo complesso
quanto entrambe le parti coinvolte nella sua funzione segnica.
Cominciamo dalla parte più semplice, l'arbitrarietà, della quale, tanto per iniziare, possiamo mantenerne la nozione ingenua dell'uso ordinario, salvo poi precisarne il significato dopo averne esaminato le principali manifestazioni.
Che il significante sia arbitrario riesce abbastanza intuitivo: se esistesse una ragione intrinseca per cui un dato concetto debba essere espresso con una particolare immagine fonica, non capiremmo, ad es., perché il concetto per 'albero' debba essere espresso in modo diverso in italiano, albero, in francese, arbre, in cinese, shù, in giapponese, ki, e così via: in tutte le lingue dovremmo ritrovare grosso modo la stessa espressione, il che chiaramente non è.
Forse meno scontato è che anche la definizione dei "concetti" (i significati, ossia) sia arbitraria, ossia idiosincratica di ogni "langue". Chiunque abbia qualche esperienza di traduzione sa però che molto spesso non vi è una effettiva corrispondenza biunivoca tra due o più concetti in lingue diverse: è il fenomeno per cui, parlando informalmente, diciamo, ad esempio, che "in italiano non c'è la parola per l'inglese sibling", e così via; più correttamente dovremmo dire che l'italiano non individua come concetto specifico 'la comune discendenza da un'unica coppia di genitori' e non la esprime con una specifica immagine acustica. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli; per iniziare da casi semplici e da lingue occidentali si considerino ad es. 'gamba' e 'carne'
| Italiano | Inglese | Tedesco | Finnico |
| gamba | leg | Fuss | jalka |
| piede | foot | " " | " " |
| Francese | Inglese | Italiano | Ungherese |
| viande | meat | carne | hús |
| chair | flesh | " " | " " |
[tav. 3]
Diversa divisione dei campi semantici in lingue diverse: i termini per 'gamba - piede'
e per 'carne' in alcune lingue europee.
Naturalmente, oltre alle corrispondenze nette 1:2 come le precedenti,
non mancano anche i casi in cui le corrispondenze sono distribuite in modo più confuso.
Un esempio ben noto (in questa formulazione risale a Hjelmslev) è quello dei nomi di
colore (che sono un buon esempio di un campo lessicale che ricopre una realtà continua, non "naturalmente" segmentabile)
in inglese e gallese:
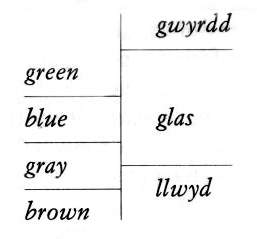
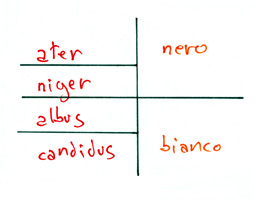
[tav.4ab]
«Confrontando il gallese e l'inglese per esempio, troviamo che all'inglese green
corrispondono in gallese gwyrdd o glas; a blue corrisponde glas; a gray corrispondono
glas o lwwyd; a brown corrisponde llwyd. Cioè, la parte dello spettro coperta
dall'inglese green è tagliata in gallese da una linea che assegna una parte di tale
zona alla parola gallese che copre anche l'area dell'inglese blue, mentre la
distinzione inglese tra green e blue non si trova in gallese. In gallese mancano
anche le distinzioni inglesi tra blue e gray e fra gray e brown; d'altra parte,
l'area coperta dall'inglese gray è suddivisa in gallese e attribuita in parte
all'area che corrisponde a blue e in parte all'area che corrisponde a brown».
Citazione e tavola riprodotti da Louis Hjelmslev, I fondamenti della teoria del linguaggio,
Introduzione e traduzione di Giulio C, Lepschy, Torino, Einaudi, 1968, pp. 57-58.
Bianco e nero in latino ed italiano: come inglese e gallese sono lingue "vicine", italiano e latino
sono uno la continuazione dell'altro, eppure hanno sistemi costruiti ben diversamente,
anche se questa volta in modo simmetrico. Il latino è sensibile all'opposizione tra opaco
e riflettente, mentre l'italiano la ignora: in latino un cristallo di tormalina è niger
mentre la fuliggine è atra; entrambi in italiano sono semplicemente neri.
In realtà, quando parlavamo dei nomi di colore come di un continuo lessicale non "naturalmente"
divisibile, semplificavamo moltissimo (la bibliografia sull'argomento è in effetti enorme). In effetti andrebbe distinto
(1) il fenomeno fisico dell'assorbimento luminoso, dall'altro (2) fenomeno fisico della natura dei nostri
recettori sensoriali (conidi e bastoncelli) che producono l'immagine "colorata" nella retina, e dalla (3) nostra
lettura mentale di essa. E propriamente (2), il nostro "spazio" visivo, non è continuo
ma "costruito" dai nostri recettori: ha infatti 3 definite dimensioni, la (a)
tonalità (quello che col termine inglese cui Photoshop e simili programmi di grafica ci hanno
reso avvezzi sarebbe hue), in cui la configurazione dei nostri fotoricettori determina
quattro colori primari, il rosso il giallo il verde ed il blu, la (b)
luminosità, con il bianco ed il nero, e la (c)
saturazione, cioè la "purezza" del colore. Ma (1) e (3) lo sono; e quello
che qui ci interessa è propriamente il solo (3): che (2), che non è linguistico
ma bensì fisico, non sia arbitrario non è affatto in questione, ed è ai fini del nostro discorso irrilevante.
La gamma dei colori è costituita da un intervallo di frequenze di
assorbimento luminoso la cui segmentazione è giocoforza "arbitraria", e gallese ed
inglese sono lingue linguisticamente assai diverse (una è celtica e l'altra è germanica)
ma "culturalmente" (storicamente, geograficamente, politicamente ...) sono lingue
assai vicine. Se proviamo il caso contrario (lingue culturalmente distanti, ma dominio
semantico di base, che penseremmo quindi non "arbitrariamente" scomponibile), inoltre,
la situazione non cambia di molto: un buon esempio è quello dei termini per ciò che ricopre
i corpi (capelli, peli, pelliccia, piume, lanugine vegetale ecc.) in inglese e malese
(una lingua austronesiana):
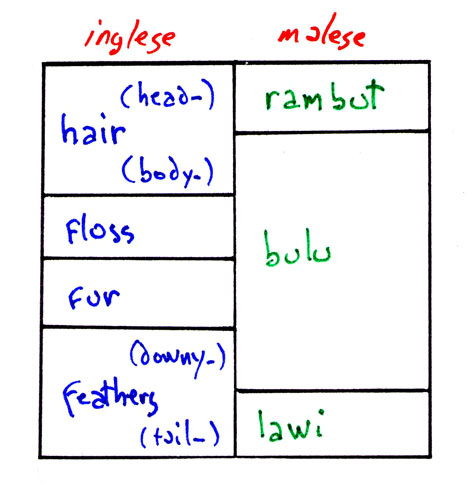
[tav. 5]
Un esempio di concettualizzazioni diverse ed asimmetriche di un'area semantica di base,
'ciò che ricopre i corpi', in due lingue in tutti i sensi distanti, inglese e malese: il malese
sembra concettualizzare come distinti solo i capelli e le piume della coda, laddove tutto
il resto è indistinto, è considerato la stessa cosa; prospettiva molto "strana" per noi. Si noti
che a volte ad un termine dell'inglese ne corrispondono due nel malese, come hair :
rambut + bulu, che sembra la stessa differenza tra 'peli della testa'
capelli e 'peli del corpo' peli che abbiamo in italiano, anche se rambut
è più esteso di capelli applicandosi anche ad oggetti per i quali noi preferiremmo
peli, per cui ad esempio il frutto, simile ad un riccio rossastro, e diffusissimo
in Asia, del Nephelium lappaceum in malese è detto rambutan (ma in sundanese,
un'altra lingua austronesiana, si ha buluan), nome col quale è generalmente noto (per
modo di dire) anche in Occidente. Ma a volte ad un termine del malese ne corrispondono
fino a cinque dell'inglese (bulu : hair + (downy) feathers + floss
+ fur) mentre ad un altro termine del malese non ne corrisponde uno specifico in inglese
(lawi : tail feathers). Basato su Robert Blust, The Austronesian Languages,
Canberra, Australian National University - Research Shool of Pacific and Asian Studies,
2009 "Pacific Linguistics" 602, p. 333.
In generale, infatti il grado di diversità delle griglie concettuali tra due lingue è
di solito proporzionale alla distanza culturale, antropologica, delle comunità che di
quelle lingue fanno uso.
| Inglese | Giapponese | Genere | Grado | Relazione | |
| brother | otooto | maschile | minore | io | 'my younger brother' |
| otooto-san | maschile | minore | tu | 'your younger brother' | |
| ani | maschile | maggiore | io | 'my older brother' | |
| oniisan | maschile | maggiore | tu | 'your older brother' | |
| sister | imooto | femminile | minore | io | 'my younger sister' |
| oimooto-san | femminile | minore | tu | 'your younger sister' | |
| ane | femminile | maggiore | io | 'my older sister' | |
| oneesan | femminile | maggiore | tu | 'your older sister' |
[tav. 6]
La suddivisione dell'area semantica di 'sibling' (per l'italiano cfr. sopra)
in inglese e giapponese. L'esempio è adattato dal sito
Introduction to F. de Saussure
di Earl Jackson Jr.
Non solo. "Arbitrario" è anche quali siano le categorie e relazioni
logiche che una lingua sceglie di rappresentare obbligatoriamente, ed il modo in cui le
categorizza nella grammatica: in altre parole, quali siano le classi di "morfemi" (i
segni linguistici minimi, cioè le unità più piccole dotate di significato) e come
questi si costituiscano in "parole" (qualsiasi cosa che poi intendiamo con, appunto, questa parola:
formalmente la nozione è delle più problematiche - cfr. ad es. Giorgio Graffi, La
parola tra "unità concreta" e "unità astratta", in "Incontri linguistici" XXXI (2008)
41-75 - ma atteniamoci pure per ora alla nozione "ingenua" che sicuramente ne abbiamo).
Più in generale, già la scelta di quale debbano essere le parole di una lingua, intese
come le "voci" primarie del suo lessico (pensate alle entrate, lemmi, di un dizionario),
contrappone lingue con strategie opposte: da una parte parole tendenzialmente coincidenti
con i segni minimi, numerosissime, inanalizzabili e con significati spesso peculiari, e
dall'altra parole quasi sempre costituite da più segni minimi (polimorfemiche), con pochi
morfemi lessicali primari che generano per abbinamento ad altri moltissime parole
complesse. Nella tavola seguente è contrapposta la strategia del primo tipo nelle lingue
austroasiatiche con quella
del secondo tipo delle lingue sinotibetane.
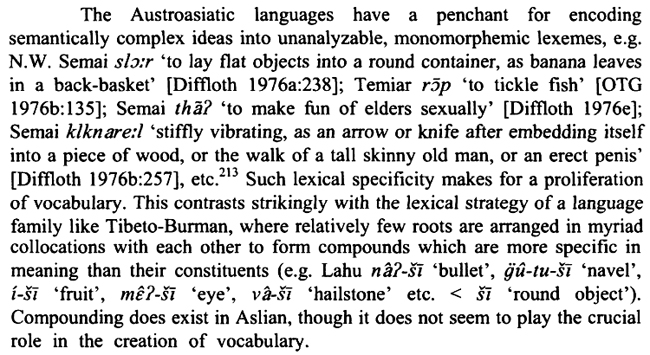
[tav. 7]
Un esempio di differenza di strategie nella formazione della parole, ossia di arbitrarietà
nella definizione del lessico primario: da una parte le lingue
austroasiatiche,
esemplificate con le arcaiche lingue asliche della Malesia, e dall'altra le lingue
sinotibetane, esemplificate con
una lingua lolo-birmana
(ma pensate anche al cinese, se volete).
Da James A. Matisoff, Aslian: Mon-Khmer of the Malay Peninsula [with notes by
Geoffrey Benjamin], in "Mon-Khmer Studies Journal" XXXIII (2003) 1-58, pp. 48-49.
Per l'arbitrarietà più propriamente delle categorie grammaticali,
poi, nel modo più elementare basta già confrontare l'italiano con l'inglese. La parola
italiana muro è formata da due morfemi, quello lessicale mur- che ha
il significato 'muro' e quello flessionale -o che ha il significato 'genere
maschile, numero singolare'; la parola grossomodo corrispondente in inglese è wall
che però è formata da un morfema solo, quello lessicale col significato di 'muro'. In effetti
in inglese sono moltissime le parole monomorfematiche, costituite da un unico morfema,
mentre in italiano sono abbastanza rare.
Come per l'arbitrarietà del significato, anche per l'arbitrarietà delle categorie
grammaticali la differenza, comunque sempre presente, cresce moltissimo se ci spostiamo
a considerare lingue tipologicamente ed antropologicamente molto distanti dal nostro
vecchio Occidente. Ad esempio, nel verbo italiano sono possibili, oltre ai morfemi
lessicali, ed a pochi morfemi derivazionali (che servono, cioè a trasformare la
classe di una parola: pietr-a > im-pietr-are), solo i morfemi di tempo/aspetto
(ad es. presente, imperfetto), modo (indicativo, ecc.), diatesi (passivo, ecc.) e persona;
raramente, pertanto, si hanno parole con più di tre o quattro morfemi. In atsugewi, una
lingua Palaihnih della California NE estintasi nel 1988, erano possibili forme verbali
complesse e sorprendenti quanto alle categorie espresse come la seguente (fonte:
Leonard Talmy, Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms,
in Language Typology and Syntactic Description. III, edited by Timothy Shopen,
Cambridge University Press, 1985, pp. 57-149, es. a p. 109; riportato anche da Marianne Mithun,
The Languages of Native North America, Cambridge (UK), Cambridge University
Press, 1999, p. 471): mphol:úphmik:a che significa (lascio in inglese
traducenti e glosse come dalla fonte) 'you spat your candy ball into his face',
cioè letteralmente 'you caused a small shiny spherical object to move into his
face by acting on it with your mouth egressively', dato che va analizzato nei morfemi
componenti mw- ... -a '2/3.FACTUAL' -phu- 'egressively from the mouth'
-lup- 'for a small shiny spherical object to move or to be located' -mik:-
into the face'. L'esempio, credo, si commenta da solo ...
I pochi casi che abbiamo visto dovrebbero avere illustrato come si strutturi l' "arbitrarietà del segno", ma dovremmo ancora meglio precisare che valore, anche teorico, essa abbia, per poi poter vedere in che misura sia legata alla nozione di "convenzionalità".
Non è ormai, dopo la rassegna precedente, difficile vedere che la nozione
saussuriana di arbitrarietà non è nel senso di 'casuale, aleatorio', ma bensì
nel senso che il segno non è "causato" (non è
determinato da relazioni necessarie di causa ed effetto) e non è "motivato" (non è
determinato da alcun rapporto di somiglianza, ossia non presenta motivazione):
per riprendere l'esempio della tav. 2, la rappresentazione fonica albero
non è determinata da alcun rapporto di causa-effetto né di somiglianza con il concetto
'albero' della lingua italiano ("langue"), né il segno linguistico "albero" della medesima
lingua è determinato da alcun rapporto causale o di somiglianza con la classe degli
oggetti del mondo ("alberi") cui può riferire. Questo non significa, naturalmente, che
non debbano esistere "segni motivati" (anzi, nella
tradizione della semiotica di Peirce questi
sono di norma chiamati "icone", in quanto il significante intrattiene con il significato
un rapporto di "somiglianza"), ma solo che i segni linguistici di norma non lo sono.
Ho detto "di norma": va infatti detto che sono state talora (già dallo stesso Saussure)
notate delle particolari aree della lingua in cui la motivazione appare determinante: si tratta,
in generale, delle onomatopee (ad es. il "sibilare" del vento o l' "ululare" del lupo)
e del lessico cosiddetto espressivo (ad es. "mamma", "bua", "pupu", ecc.).
Il fenomeno è indubbiamente reale, ma che incidenza può avere nel sistema di una lingua?
Proviamo a considerare, ad esempio, le riproduzioni "linguistiche" (onomatopee)
dei versi degli animali (purtroppo non è più online l'efficace sito
Sound of the
World's Animals di Catherine N. Ball, una linguista americana attiva soprattutto
nel campo della linguistica computazionale e della filologia germanica, cfr. il suo
profilo), anche solo accontentandoci
del confronto delle forme inglesi fornite da Wikipedia
con quelle italiane che (presumibilmente) già sappiamo: ciò può suggerire interessanti
considerazioni. Noterete, infatti, che
le parole con cui vengono riprodotti i versi degli animali presentano indubbiamente una
qualche somiglianza con i suoni originali (sono, ossia, "motivati"), ma sono anche spesso
radicalmente diverse tra loro in italiano ed inglese. In altre parole, se il principio della
motivazione fosse fondamentale ci aspetteremmo una somiglianza maggiore tra le
espressioni delle varie lingue, ed, anzi, se fosse in gioco un vero principio causale
ci dovremmo aspettare una identità totale. In realtà, anche in questo caso, la
convenzionalità finisce per avere la meglio, confermandosi come la caratteristica
dominante.
Abbiamo visto come Saussure dimostri convincentemente come la
langue sia arbitraria. Questo, va osservato, è in un certo modo contrario alla
naturale tendenza che "ingenuamente" avremmo, in quanto insita nella natura stessa
della creazione dei miti: Ernst Cassirer
(1874-1945; è il grande filosofo e storico della filosofia autore della
Logica delle forme simboliche) osservava infatti che
«The notion that name and essence bear a necessary and internal relation to each
other, that the name does not merely denote but actually is the essence of
its object, that the potency of the real thing is contained in the name - that is
the one of the fundamental assumptions of the mythmaking consciousness itself»
(Ernst Cassirer, Language and Myth, translated by Susanne K. Langer, Harper
& Brothers 1946, Repr. New York, Dover Publications).
Non a caso in molte culture "primitive"
(dalle Americhe all'Africa all'Oceania) scoprire il nome del nemico equivale a
catturarne l'essenza, ad averlo magicamente in proprio potere. E comunque non mancano
sopravvivenze archetipiche di questo schema anche nella nostra cultura, in aree
che vanno dalla tradizione popolare alla finzione artistica. Un esempio che tutti
dovremmo in qualche modo aver presente (chi non ha mai sentito il Nessun dorma? -
non fosse che per "colpa" di Pavarotti) è la Turandot di
Puccini
1858-1924 (basata, non a caso su una
"favola" del settecentista veneziano Gasparo Gozzi 1713-1786), nella quale
la prova cruciale, che deve decidere della vita o della morte dell'eroe,
è proprio la scoperta del suo nome:
CALAF:
Tre enigmi m'hai proposto,
e tre ne sciolsi.
Uno soltanto a te ne proporrò:
il mio nome non sai.
Dimmi il mio nome.
Dimmi il mio nome
prima dell'alba,
e all'alba morirò!
[tav. 8]
Il finale dell'atto II della Turandot di Puccini (l'
e-text
del libretto, con anche una traduzione spagnola, è liberamente accessibile dal
sito KAREOL)
Il problema è, in effetti, vecchio almeno quanto la nostra cultura
(se non più), e si trova filosoficamente impostato già in un dialogo di
Platone
428 - 347 a.C, il Cratilo, che si può a ben diritto considerare
il primo testo di linguistica e di filosofia del linguaggio del nostro Occidente.
Nel dialogo partecipano tre personaggi, Ermogene, Cratilo e Socrate, e discutono
di come i nomi siano relati alla realtà:
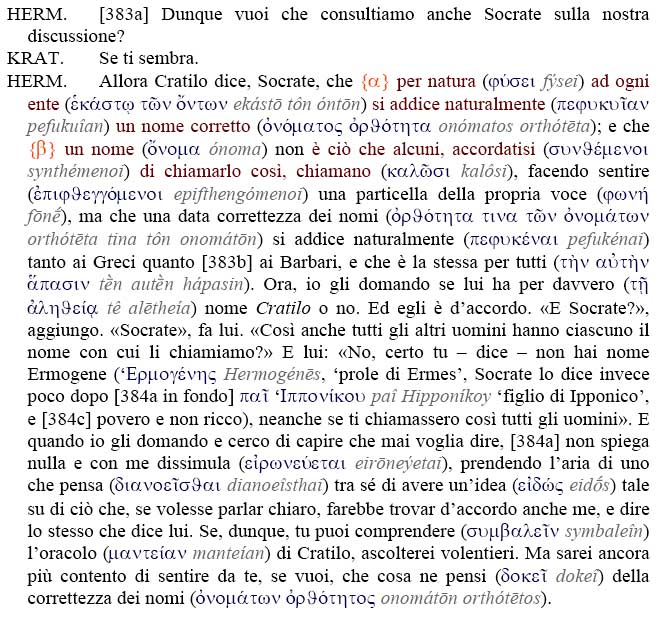
[tav. 8]
L'inizio del Cratilo con la dichiarazione del tema principale del dialogo.
Mancano (sembra incredibile) buone traduzioni italiane del dialogo (al meglio sono
antiquate, scritte in italiano obsoleto), anche se un
e-text
del dialogo è liberamente disponibile in versione inglese sul sito del
Project Gutenberg.
Così per questa, cruciale porzione del dialogo
(è un po' il lever de rideau, l'alzata del sipario, su tutta la linguistica
occidentale...) vi dò una traduzione mia, con lo stesso sistema che avevamo visto
per il De interpretatione
di Aristotele: evidenziate in mattone sono le tesi principali, numerate tra {uncinate} arancioni;
in blu sono dati i termini greci originali, trascritti in grigio; in verdone tra
[quadre], infine, la numerazione Stephanus.

[tav. 10]
La numerazione tra quadre del testo nella tavola precedente è quella di pagina e
sezione della prima e storica edizione di Platone del 1578, approntata dallo Stephanus, monumento ancora
fondamentale e comunemente usata come riferimento assoluto: ne riproduco il frontespizio.
Dell'edizione dello Stephanus bene dice la Internet
Encyclopedia of Philosophy: «Except for the Timaeus, all of Plato’s works were lost
to the Western world until medieval times, preserved only by Moslem scholars in the Middle East.
In 1578 Henri Estienne (whose Latinized name was Stephanus) published an edition of the
dialogues in which each page of the text is separated into five sections (labeled
a, b, c, d, and e). The standard style of citation for Platonic texts includes the
name of the text, followed by Stephanus page and section numbers (e.g. Republic 511d).
Scholars sometimes also add numbers after the Stephanus section letters, which refer
to line numbers within the Stephanus sections in the standard Greek edition of the
dialogues, the Oxford Classical texts.»
Se in queste prime battute del dialogo l'impostazione del problema pare
chiara, e sono già messe su tappeto le parole chiave, i concetti, che saranno
determinanti in tutta la tradizione filosofica successiva, a partire da quel
De interpretatione
di Aristotele che avevamo già iniziato a leggere (e cui vi invito ora a ritornare), pure il Cratilo,
nel suo complesso, è un dialogo difficile e problematico. Già la sua datazione
è incerta: chi lo crede giovanile (c. 390 - 385 a.C.), od al limite appena precedente il
Simposio, chi, appunto, intermedio (c. 380-360 a.C.) affine al Fedone,
chi tardo (c. 355-347 a. C.), a complemento del Teeteto e del Sofista,
e chi, a mio parere più verosimilmente, come ripreso più volte e con rifacimenti
di epoche diverse. Non solo, fin la sua autenticità
è stata messa in dubbio, sia pure con argomentazioni assolutamente non convincenti.
Anche dal punto di vista della sua struttura il dialogo è strano, o perlomeno
anomalo tra gli altri dialoghi platonici, in quanto il personaggio eponimo, Cratilo,
non parla praticamente mai, e la maggior parte del dialogo è occupata da un lunghissimo
sproloquio etimologico di Socrate, in genere folle od incomprensibile (è la principale
ragione per cui qualcuno ha dubitato dell'autenticità del dialogo; forse è una presa
in giro, che più non comprendiamo, di qualche filosofo dell'epoca di cui abbiamo perso
fin la memoria). I personaggi del dialogo, tra l'altro, sono figure storiche:
di Cratilo sappiamo qualcosa, oltre che dal dialogo platonico, ed a parte alcuni
riferimenti più tardi e derivativi (Diogene Laerzio ed altri), da pochi ma importanti
passi di Aristotele (Metafisica 987a e 1010a, e Retorica 1417b),
che ce lo tratteggia come un seguace di Eraclito (il presocratico, ricordate?, cui si
attribuisce l'idea che tutto sia cambiamento, non ci può bagnare due volte nell'acqua
dello stesso fiume, ecc.) con cui Platone sarebbe stato in
notevole rapporto da giovane; di Ermogene sappiamo invece ben poco, se non che era un sodale di
Socrate (in base al Fedro 9b) e che ne fu presente (secondo Senofonte) alla morte.
Già da questi preliminari però si possono trarre alcune osservazioni: la tesi
convenzionalista viene connessa ad un personaggio "postsocratico" ed è pertanto "nuova", "filosofica";
la tesi naturalistica viene connessa ad un personaggio "presocratico" ed è pertanto
precedente la "nascita della filosofia", sapienziale: non a caso come la "sapienza" greca arcaica
ha connessioni orientali, così la teoria naturalistica del linguaggio si identifica
con quella caratteristica della cultura egiziana:
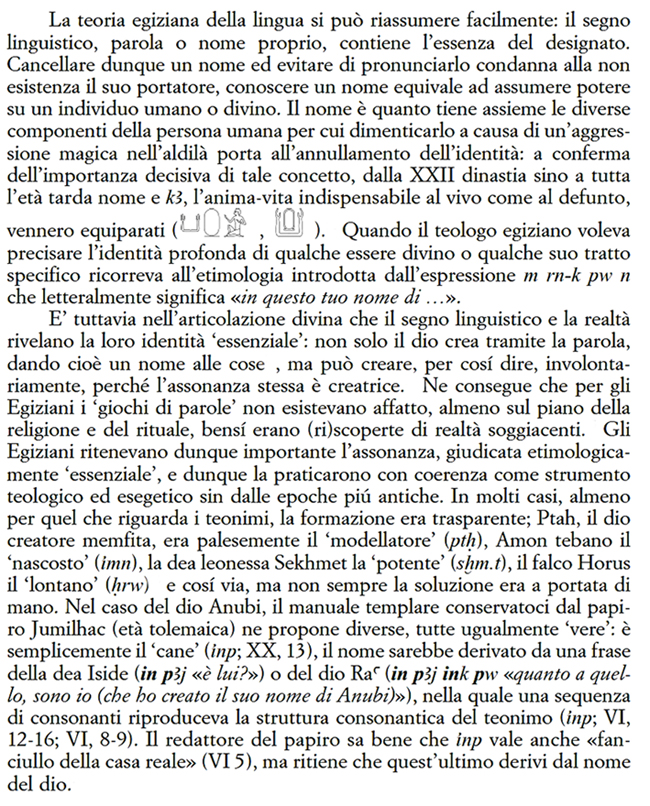
[tav. 11]
La linguistica secondo gli antichi egizi: un cratilismo orientale. Pp. 126-7 da
Franco Crevatin, Egitto antico ed etimologia, in L'etimologia. Atti del XXXV Convegno
della Società Italiana di Glottologia. Napoli, 21-23 ottobre 2010, testi raccolti a cura di
Alberto Manco e Domenico Silvestri, Napoli, Il Calamo, 2010, pp. 123-155
Complessivamente il dialogo, che pure è stato spesso letto nei modi
più diversi, sembra condensabile come nelle prime battute che abbiamo letto poc'anzi:
Cratilo sostiene che i nomi sono adeguati per natura (phúsis), Ermogene invece
che non sono dovuti alla natura ma bensì ad una legge (nómos) od al costume
(éthos). Nel resto del dialogo Socrate, invece, dapprima (c. 8 pagine) porta argomenti contro
Ermogene, sostenendo che le parole non sono arbitrarie, poi (c. 37 pagine) si lancia (contrappuntato
sempre dal solo Ermogene) nella lunga e folle cavalcata etimologica che occupa la
porzione centrale del dialogo, ma poi (c. 14 pagine) nell'ultima parte porta argomenti anche contro
Cratilo (che finalmente parla, se pure per poco!), sostenendo che studiare il
linguaggio non serve a conoscere il mondo.
Cosa davvero ne pensi Platone, come spesso nei suoi dialoghi, non è facile da stabilire.
Ma bisogna spingersi oltre e leggere più a fondo il dialogo per rendersi conto della sua
importanza. In mancanza di buone traduzioni (prima vi ho riferiti all'e-text inglese,
che almeno è gratuito; un buon riassunto critico, sempre in inglese, è anche disponibile
online nella Stanford
Encyclopedia of Philosophy) la nostra chiave di accesso in italiano, non potendo
tradurvelo ora tutto io, potrebbe essere la versione compendiaria (ma l'essenziale
c'è tutto) che ne dà Peter Matthews, almeno per la prima e l'ultima sezione del dialogo,
trascurando quasi in toto la sezione etimologica, con qualche ulteriore taglio e
poche inserzioni e farciture:
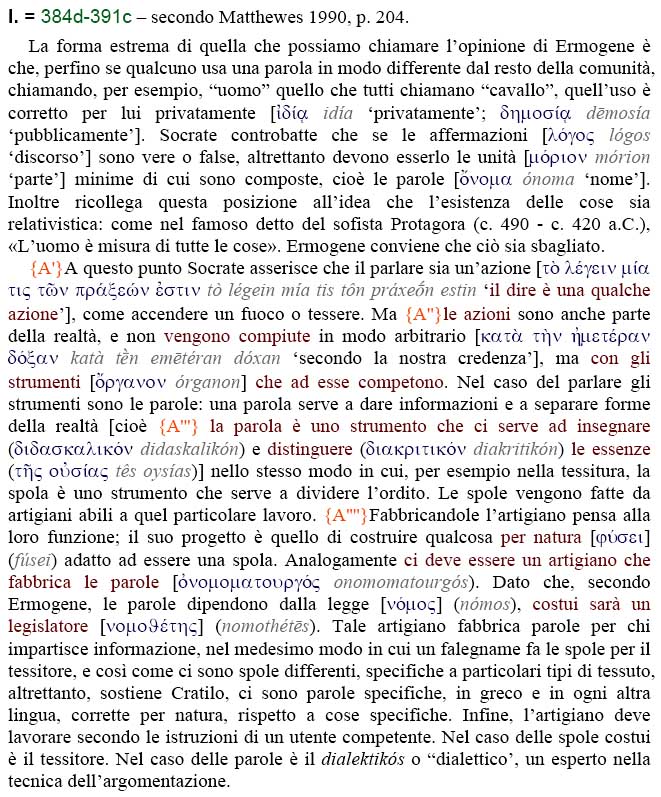
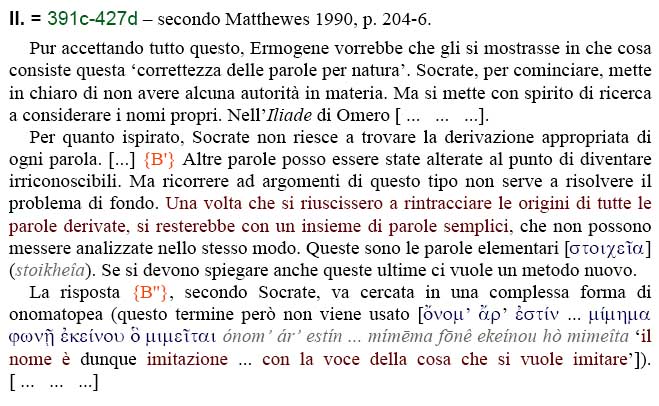
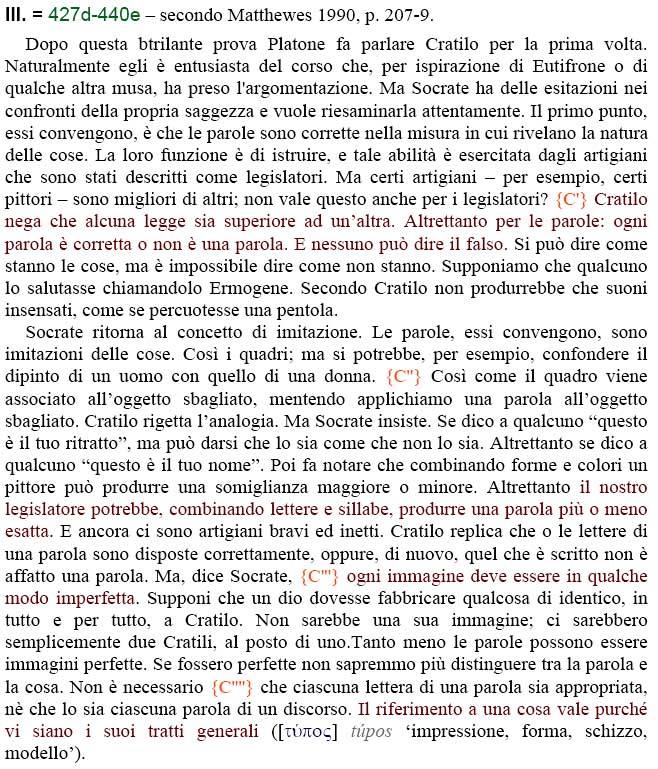
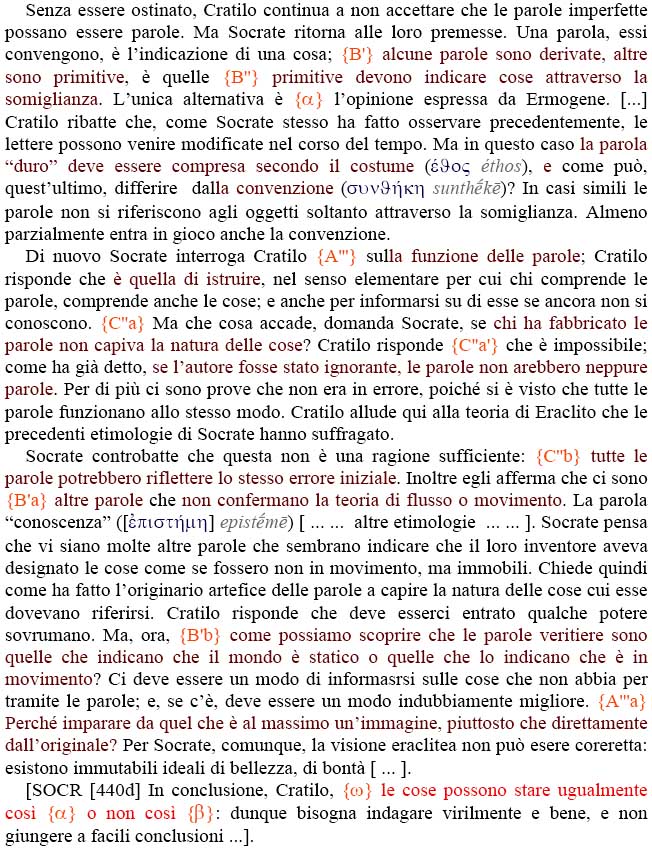
[tav. 12abc]
Un riassunto delle parti principali del Cratilo: adattato da Peter Matthews, La linguistica greco-latina,
in Storia della linguistica a cura di Giulio C. Lepschy, Vol I, Bologna, Il Mulino,
1990, pp. 187-310 (in particolare pp. 203-209), con tagli ed inserzioni (tra quadre).
Mio è il sistema di colori e la segnalazione della principale struttura argomentativa,
già usato nella tavola precedente (con il "prologo" del dialogo tradotto integralmente)
e per il De interpretatione
di Aristotele: evidenziate in mattone sono le tesi
principali e secondarie, numerate tra {uncinate} arancioni (con lettere greche per le
due alternative principali, e latine maiuscole + apici + minuscole per le altre tesi;
in blu sono dati i termini greci originali, trascritti in grigio; in verdone tra
[quadre], infine, la numerazione Stephanus.
Nella proposta di lettura che (a partire dal Matthew) vi ho presentato
le tesi principali sono due, quelle che ho marcato come {A} e {C}. Nell'una, {A},
nella prima parte, Socrate muove contro Ermogene, ma in realtà elabora una tesi
parzialmente "mista": l' "onomaturgo", l'artigiano che fabbrica le parole in base all'uso cui
"per natura" sono destinate, è anche un "legislatore" (nomothetes. Nella seconda, {C},
Socrate muove contro Cratilo, in base alla sua assunzione che se le parole sono per natura
"giuste" non è possibile dire il falso (a tesi {C}, tra l'altro, è probabilmente vera
dal punto di vista storico: è attribuita a Cratilo anche dalla testimonianza di Aristotele, che a
commento racconta come Cratilo andasse oltre Eraclito sostenendo che non solo non ci può bagnare la
seconda volta nello stesso fiume, ma neppure la prima!). In mezzo, dalla farragine etimologica, si estrae
una tesi {B} "eraclitea" sul cambiamento delle parole del tempo (in termini moderni, diremmo sul
mutamento diacronico, introdotta per sostenere {A}, ma variamente utilizzata per
{C}. Dopo l'introduzione e la discussione di {C}, vengono portate e subito contrastate
altre versioni parziali o modificate della tesi di Cratilo, e vengono riprese e discusse
altre tesi dette precedentemente, ma sostanzialmente la discussione sembra
sfaldarsi, finché, alla fine, i tre amici se ne vanno, e Socrate dice, testualmente, che
le cose possono stare così (come dice Cratilo) o no: ma l'importante è pensarci bene sopra.
Ed in effetti è più di una ventina di migliaia d'anni che ormai ci pensiamo ...
Al di là della sensazione (frequente nei dialoghi platonici) di trovarci con un pugno di mosche,
e difficoltà interpretative a parte, nel dialogo vi sono molti spunti da cogliere,
e non solo quello di avere per la prima volta impostata la questione, sia pure in termini
ancora molto eraclitei e non sempre moderni. Storicamente, infatti, Aristotele,
che la riprende nel De interpretatione
(su cui vi invito a ritornare ancora adesso) risolvendola in senso convenzionalistico
come ancora noi oggi, parte comunque dai concetti (e spesso dalla terminologia) di Platone: da quello
di "convenzione" (sunthéke) e di natura (fúsis), a quello di "voce" (foné),
a quello stesso di parola (onoma che è normalmente non solo 'nome' ma anche 'verbo');
dove Aristotele va drasticamente al di là di Platone è soprattutto nel concetto di verofalsità
come proprietà non del nome ma della proposizione (e se vi insiste tanto, ad apertura del
De interpretatione
è proprio probabilmente in polemica col Cratilo),
vanificando del tutto l'argomento {C} e rendendo inutile le sue confutazioni. Inoltre,
anche le concezioni del linguaggio come "azione" e della sua funzione principale di "insegnare"
qualcosa sul mondo avranno dei robusti eco nella filosofia contemporanea, a partire da
Wittgenstein
e poi della filosofia del linguaggio comune e della teoria degli atti linguistici.
Un'ultimo punto, infine: Platone distingue chiaramente i concetti di arbitrario
("secondo la nostra credenza") e convenzionale katà sunthéke, come farà poi Saussure,
ma nella tradizione occidentale presaussuriana i due concetti avevano finito per conguagliarsi (donde la necessità
di Sussure di ri-distinguerli), in base ad un fraintendimento della versione di Boezio
(480 c. - 524 d.C) che aveva correttamente volto katà sunthéke con il latino
secundum placitum 'secondo un accordo (il placitum era la sentenza
di un giudizio)', ma medievalmente il significato di ad placitum e simili diviene
'come vi pare e piace' («secondo che v'abbella» dice Adamo a Dante nella Commedia),
cioè il medesimo di arbitrario.
Comunque, quello che a noi ora preme è avere, in qualche modo, definito il tema della "naturalità" del linguaggio ed averne verificato la costante presenza tanto nel pensiero mitico come nella riflessione linguistica occidentale, non fosse che per meglio valutare le posizioni "convenzionaliste" di Saussure.
Col che, dopo questo interludio mitico e filosofico, siamo ormai
giunti, adeguatamente preparati, al secondo aspetto della teoria saussuriana, quello della convenzionalità:
perché un determinato segno, arbitrario, divenga davvero "linguistico" deve esserci
il consenso ideale (convenzione) di una comunità di parlanti circa il suo uso.
Se ognuno, ad esempio, assegnasse di proprio arbitrio espressioni ai concetti finirebbe
come Humpty-Dumpty, il personaggio di Lewis Carroll in un famoso passo di Behind the looking glass
(l' e-text
è scaricabile liberamente dal Project Gutemberg):
'I don't know what you mean by "glory,"' Alice said.
Humpty Dumpty smiled contemptuously. 'Of course you don't -
till I tell you. I meant "there's a nice knock-down argument for
you!"'
'But "glory" doesn't mean "a nice knock-down argument,"' Alice
objected.
'When _I_ use a word,' Humpty Dumpty said in rather a scornful
tone, 'it means just what I choose it to mean - neither more nor
less.'
'The question is,' said Alice, 'whether you CAN make words mean
so many different things.'
'The question is,' said Humpty Dumpty,
'which is to be master - that's all.'
Alice was too much puzzled to say anything, so after a minute
Humpty Dumpty began again. 'They've a temper, some of them -
particularly verbs, they're the proudest - adjectives you can do
anything with, but not verbs - however, _I_ can manage the whole
lot of them! Impenetrability! That's what _I_ say!'
'Would you tell me, please,' said Alice 'what that means?'
'Now you talk like a reasonable child,' said Humpty Dumpty,
looking very much pleased. 'I meant by "impenetrability" that
we've had enough of that subject, and it would be just as well
if you'd mention what you mean to do next, as I suppose you don't
mean to stop here all the rest of your life.'
'That's a great deal
to make one word mean,' Alice said in a thoughtful tone.
'When I make a word do a lot of work like that,' said Humpty
Dumpty, 'I always pay it extra.'
'Oh!' said Alice. She was too
much puzzled to make any other remark.
'Ah, you should see 'em come round me of a Saturday night,'
Humpty Dumpty went on, wagging his head gravely from side to
side: 'for to get their wages, you know.'
(Alice didn't venture to ask what he paid them with; and so you
see I can't tell YOU.)
[tav. 13]
Un bizzarro "padrone" del linguaggio, che fa fare alle parole quello che vuole
solo lui: Humpty-Dumpty.
Nonostante che espresso in termini informali ed intuitivi il concetto
di convenzialità sia abbastanza chiaro, si tratta in realtà di un termine molto
discusso in filosofia, non fosse che perché copre concetti di natura anche abbastanza
diversa.
La convenzionalità di Saussure non è ad esempio quella della filosofia
del diritto (dove poggia su un consenso esplicito dei cittadini ai codici normativi)
o della politica (la posizione "giusnaturalistica" prevede che lo stato e le sue
basi legali siano istituite da una decisione esplicita degli abitanti), come neppure
quella della filosofia della matematica (dove investe la "realtà" o meno dei numeri)
o della logica (dove implica la natura "umana" e contingente, anziché a priori
e/o trascendentale, dei primitivi logici). Verso le ultime due problematiche, Saussure
nulla ipoteca sui principi della logica (che sono semmai una precondizione della possibilità
di un linguaggio, non la "langue" stessa), e verso le prime due non ha l'idea "ingenua" del consenso
esplicito avvenuto in un determinato momento della storia ad opera di un definito gruppo
di uomini (come avvenuto, ad es., per la nostra costituzione).

[tav. 14]
Uno spiritoso esempio di come si può creare una convenzione, tratto dalle classiche strisce preistoriche
di John Hart, B.C., e risalente agli anni '60. Da Johnny Hart's Growing Old with B.C. A 50 Year Celebration,
West Carrollton (OH), Checker Book Publishing Group, 2007, p. 74.
La "langue" (che è il livello specifico al quale si esercita la convenzionalità
in Saussure), possiamo invece concludere, è una creazione storica
ed antropologica, ed è il risultato dell'uso del linguaggio da parte di una determinata
società di parlanti in un determinato momento della storia. La convenzione non è circoscritta
ad un momento iniziale istitutivo, ma è sempre in atto, radicata nell'uso che una comunità
fa della lingua, rinegoziata ad ogni atto linguistico, al cui esito felice ("felicità")
tutti i partecipanti devono cooperare ("principio di cooperazione"), come evidenzierà Grice e
la teoria degli atti linguistici, teoria che si svilupperà da una costola di Wittgenstein,
filosofo che è giunto, su questo punto, a risultati affatto confrontabili a quelli di Saussure.
La prospettiva "antropologica" della lingua di Saussure che abbiamo delineato
nel paragrafo precedente anticipa di cinquant'anni, va infatti sottolineato, alcune delle
tesi di una delle più importanti opere della filosofia del Novecento, le Philosophische
Untersuchungen ('Ricerche filosofiche', uscite postume nel 1957) di Ludwig
Wittgenstein (1889-1951).
Wittgenstein, dobbiamo purtroppo premetterlo, è senz'altro un pensatore "difficile",
sul quale a volte anche gli specialisti faticano a trovarsi d'accordo. Questo è dovuto in parte
(a) alla natura frammentaria dei suoi scritti (praticamente tutti postumi tranne il suo primo ed unico
libro, il Tractatus Logico-philosophicus del 1921, che appartiene tuttavia ad una diversa
e poi rinnegata fase del suo pensiero, separata da una decina d'anni di interruzione
nell'attività filosofica dagli scritti, tutti incompiuti e/o frammentari, della cosiddetta
"seconda fase", che trova uno dei suoi vertici nelle Ricerche filosofiche,
pure incompiute anche se pensate per la pubblicazione); (b) al particolare
stile del suo pensiero, rapsodico e dialogante, mai da esposizione dottrinale;
(c)
alla intrinseca difficoltà dei problemi che mette sul tappeto, sulle cui soluzioni
possono esserci anche interpretazioni diverse: un pensatore "aperto" e problematico, dunque.
L'argomento che ci interessa è molto approssimativamente quello variamente svolto nella
sezione centrale della prima parte delle Ricerche (§§ 138-271) e consiste
in due tesi distinte ma tra loro legate: (1) la tesi che il significato
equivale all' uso e (2) la tesi dell'impossibilità di un
"linguaggio privato". Prima di entrare nel vivo, devo naturalmente avvertire che,
come spesso avviene con Wittgenstein, questo argomento è stato letto ed interpretato
in modi diversi; quella che qui prospetto è la lettura più influente nella
tradizione della filosofia analitica, lanciata dal filosofo americano (Nebraska, 1941) Saul
Kripke in Wittgenstein on Rules and Private language, Oxford, Blackwell, 1982
(ne esiste anche una traduzione italiana).
Aggrediamo la questione partendo direttamente dal testo, e leggendo una serie completa di paragrafi dalle Ricerche in cui siano contenuti tutti gli elementi principali
dell'argomentazione, in modo da imparare anche a conoscere il particolare stile
di pensiero di Wittgenstein, che lo rende in qualche modo sempre aperto a nuove riflessioni
(vi sono nel testo anche spunti che puntano in altre direzioni: uno deve sempre scegliere!).
197.
[... ... ...] ——— Dove viene effettuata la connessione [b'] tra il
senso delle parole "Giochiamo una partita a scacchi! [c']" e tutte le regole del giuoco?
— Ebbene, nell'elenco delle regole del giuoco, nell'insegnamento degli scacchi,
nella pratica quotidiana del giuoco [a].
198.
"Ma come può una regola insegnarmi che cosa devo fare a questo punto [e]? Qualunque
cosa io faccia, può sempre essere resa compatibile con la regola mediante una qualche
interpretazione". — No, non si dovrebbe dire così. Si dovrebbe invece dire: Ogni
interpretazione è sospesa nell'aria insieme con l'interpretato; quella non può servire
da sostegno a questo. Le interpretazioni [f], da sole, non determinano il significato.
"Dunque, qualunque cosa io faccia, può sempre essere resa compatibile con la regola?"
— Lasciami chiedere: Che cosa ha da spartire l'espressione della regola — diciamo, un
segnale stradale [d] — con le mie azioni? Che tipo di connessione sussiste tra le due
cose? — Ebbene, forse questa: sono stato addestrato a reagire in un determinato modo
a questo segno, e reagisco così.
Ma in questo modo hai solo indicato un nesso casuale, hai soltanto spiegato come mai
ora ci regoliamo secondo le indicazioni di un segnale stradale; non in che consista,
propriamente, questo attenersi ad un segnale. No; ho anche messo in evidenza che uno
si regola [j] secondo le indicazioni di un segnale stradale solo in quanto esiste un
uso stabile, un'abitudine.
199.
Ciò che chiamiamo "seguire una regola" è forse qualcosa che potrebbe essere
fatto da un solo uomo [k], una sola volta nella sua vita? — E questa,
naturalmente, è un'annotazione sulla grammatica dell'espressione "seguire
la regola".
Non è possibile che un solo uomo abbia seguito una regola una sola volta. Non è
possibile che una comunicazione sia stata fatta una sola volta, una sola volta un
ordine sia stato dato e compreso, e così via. — Fare una comunicazione, dare o
comprendere un ordine, e simili, non sono cose che possano essere fatte una volta
sola. — Seguire una regola [n], fare
una comunicazione, dare un ordine, giocare una partita a scacchi sono abitudini
(usi, istituzioni).
Comprendere una proposizione significa comprendere un linguaggio. Comprendere un
linguaggio significa essere padroni [b''] di una tecnica.
200.
Naturalmente si può immaginare [c''] che in un popolo, che non conosca giuochi,
due persone si seggano davanti a una scacchiera ed eseguano le mosse di una partita [g]
a scacchi ; e anche con tutti fenomeni psichici concomitanti. E se noi vedessimo
una cosa simile, diremmo che quelle persone giocano a scacchi. Ma immagina ora
una partita [h] a scacchi tradotta, in base a certe regole, in una serie di azioni che
noi non siamo abituati ad associare a un giuoco, — per esempio, emettere
grida o battere i piedi. E supponiamo ora che quei due, invece di giocare a scacchi
nella forma a noi familiare, gridino e pestino i piedi; in modo, però, che questi
processi possano essere tradotti, secondo regole appropriate, in una partita a scacchi.
In questo caso saremmo ancora propensi a dire che quei due stanno giocando un giuoco?
E con quale diritto potremmo dirlo?
201.
Il nostro paradosso era questo: una regola non può determinare alcun modo d'agire,
poiché qualsiasi modo d'agire può essere messo d'accordo con la regola. La risposta
è stata: Se può essere messo d'accordo con la regola potrà essere messo in contraddizione
con essa. Qui non esistono pertanto né concordanza né contraddizione.
Che si tratti di un fraintendimento si può già vedere dal fatto che in questa
argomentazione avanziamo un'interpretazione dopo l'altra; come se ogni singola
argomentazione ci tranquillizzasse almeno per un momento, finché non pensiamo a
un'interpretazione che a sua volta sta dietro la prima. Vale a dire: con ciò facciamo
vedere che [i'] esiste un modo di concepire una regola che non è un'interpretazione,
ma che si manifesta, per ogni singolo caso d'applicazione, in ciò che chiamiamo
"seguire la regola" e contravvenire ad essa".
Per questa ragione esiste una tendenza a dire che ogni agire secondo una regola
è un'interpretazione. Invece si dovrebbe chiamare "interpretazione" soltanto la
sostituzione di un'espressione della regola a un'altra.
202.
Per questo 'seguire la regola' è una prassi [i''].
E credere [l] di seguire
la regola non è seguire la regola. E perciò non si può [m] seguire una regola 'privatim':
altrimenti credere di seguire la regola sarebbe la stessa cosa di seguire la regola.
203.
Il linguaggio è un labirinto di strade. Vieni da una parte e ti sai
orientare; giungi allo stesso punto da un'altra parte, e non ti raccapezzi più.
[tav. 15]
Una sezione della prima parte delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein:
dalla fine del § 197 al § 203. Testo secondo l'edizione italiana a cura
di Mario Trinchero, Torino, Einaudi, 1967, pp. 106-109. I numeri-chiave introdotti in
verde si riferiscono alla spiegazione qui sotto proposta.
Se proviamo a rimontare la catena argomentativa avremmo qualcosa
di questo tipo (i numeri in verde rinviano al testo).
(0) La premessa è che un linguaggio è pensato come un
"gioco" costruito con regole [a],
e conoscere un linguaggio equivale a seguirne correttamente le regole
[b'] (il linguaggio è una tecnica di
cui bisogna essere padroni [b'']), donde la
frequenza degli esempi basati sul gioco degli scacchi,
[c'] e [c''],
sulle regole dei segnali stradali [d]
e simili. Per quanto riguarda la tesi (1),
cosa vuol dire seguire una regola [e]
ovvero "comprenderne il significato"? «Le interpretazioni, da sole, non determinano
il significato» [f],
come si vede dall'esempio immaginario della partita finta ma apparente
[g]
e della vera ma irriconoscibile [h],
a partire dal quale si argomenta come "seguire una regola" non sia un'interpretazione
[i'].
«'Seguire la regola' è una prassi» [i''], invece:
«uno si regola [...] solo in quanto esiste un uso stabile, un'abitudine»
[j].
A queste considerazioni si intreccia strettamente l'argomento (2)
contro il linguaggio privato: "seguire una regola" [k],
infatti, non è cosa che potrebbe essere fatta da un solo uomo, una sola volta:
come potrebbe allora sapere il significato di quello che sta facendo? «Credere di
seguire la regola non è seguire la regola» [l]: «perciò
non si può seguire una regola 'privatim'» [m].
Si noti, poi, come le conclusioni di Wittgenstein mettano capo, per quanto
riguarda la tesi (1), ad una fondazione antropologica e
convenzionalista del linguaggio affatto simile alla saussuriana («Seguire una regola,
fare una comunicazione, dare un ordine, giocare una partita a scacchi sono
abitudini (usi, istituzioni)» [n]),
e, per quanto riguarda la tesi (2), ad una (sempre gradita)
dimostrazione di quello che la linguistica strutturale e la teoria
della comunicazione (ed anche noi all'inizio delle nostre lezioni, nel
§ 1.0) avevano posto
come definizione stessa di linguaggio: il fatto che siano necessariamente
implicati più partecipanti (almeno un emittente ed un destinatario!).
Si noti, infine, che l'idea che il linguaggio sia in realtà una famiglia di diversi giochi, cioè di attività basate su regole, poggia su dei precedenti importanti: la nozione del linguaggio come una azione era nel Cratilo (che vi invito a rileggere); pure la nozione che esistono diversi tipi di uso del linguaggio è preceduta dalla consapevolezza espressa da Aristotele nel De interpretatione (che vi invito a rileggere) che esistono diversi tipi di discorso, tra qui quello apofantico (verofalso, o referenziale, che informa di stati di cose nel mondo) è solo uno; ed anche la concezione che usare un linguaggio è poterlo insegnare ha i suoi precedenti nel Cratilo. Inoltre, questi aspetti della speculazione di Wittgenstein, confermati dal coté linguistico dalla riflessione sulle funzioni del linguaggio di Jakobson che presto vedremo, hanno avuto importanti conseguenze nella filosofia del linguaggio contemporanea con la cosiddetta filosofia del linguaggio ordinario e la teoria degli atti linguistici (per cui probabilmente non avremo qui spazio, ma cui almeno dobbiamo accennare).
Un'altra fondamentale caratteristica dei segni linguistici è
che sono complessi e "discreti", tanto al loro interno (articolazione),
quanto rispetto ad altri segni (composizionalità).
Avere una articolazione anziché essere compatti significa essere scomponibili in parti tra loro
chiaramente distinte: un libro, ad esempio, è "discreto" in quanto è segmentabile
in unità distinte (capitoli, paragrafi ...), ma l'acqua contenuta in un bicchiere è
"compatta", in quanto non la posso segmentare in parti distinte (e se la dividessi
nelle sue molecole costituenti cesserebbe comunque di esistere come acqua, in quanto
non avrebbe più le determinate caratteristiche fisiche che attribuiamo all' "acqua").
Guardiamo invece un segno linguistico. L'espressione mela, ad esempio, è
chiaramente segmentabile in quattro unità sonore, fonemi (che presto approfondiremo),
facilmente identificabili procedendo a prove di commutazione locale
(Vela, mOla,
meNa, melO);
il concetto 'mela', distinto da quello di 'pera' ecc., è invece chiaramente segmentabile
in 'buccia', 'polpa', 'seme', 'picciolo', ecc.
Questa doppia articolazione del linguaggio, tanto a
livello di definizione concettuale che di segmentazione fonologica, è stata specialmente
sottolineata come costitutiva del linguaggio umano soprattutto da un altro grande
linguista che si è rifatto alla lezione di Saussure, il francese André Martinet
(1908-1999).
La correlata proprietà della composizionalità vuole che ogni segno possa
diventare a sua volta una parte discreta di un complesso di segni il cui significato
è dato dalla somma del significato delle sue parti: più parole possono formare un sintagma,
una frase, ecc... Ad esempio il significato di "risotto di zucca" è propriamente
la sommatoria dei significati risp. del nome riso 'chicchi ricavati per uso
alimentare dalle spighe dell'Oryza sativa' + il suffisso derivativo -otto
+ la preposizione di 'relazione di materia' + zucca 'la polpa succulenta
della Cucurbita pepo'.
Questo principio, in realtà, era già stato individuato dal grande logico e filosofo della matematica
Gottlob Frege (1848-1925)
in un articolo del 1892, Über Sinn und Bedeutung, ma su questo torneremo
nel paragrafo successivo.
Molte delle cose che abbiamo detto sopra sottintendevano naturalmente
un'altra caratteristica del segno linguistico, la linearità del significante:
come diceva Saussure (Cours, p. 88 dell'ed. italiana = p. 103 della francese),
«questo principio è evidente, ma sembra che ci si sia sempre dimenticati di enunziarlo,
senza dubbio perché lo si è trovato troppo semplice».
Il significante linguistico, infatti, (ibidem) «essendo
di natura auditiva, si svolge soltanto nel tempo ed ha i caratteri che trae dal
tempo: (a) rappresenta una estensione, e (b) tale estensione è misurabile in una
sola dimensione: è una linea». Saussure era già ben consapevole dell'importanza
semiologica di questa caratteristica del linguaggio umano rispetto ad altre forme
di linguaggio (ibidem): «in opposizione ai significanti visivi (segnali
marittimi ecc.) che possono offrire complicazioni simultanee su più dimensioni,
i significanti acustici non dispongono che della linea del tempo: i loro elementi
si presentano l'uno dopo l'altro; formano una catena».
Parlando della composizionalità abbiamo accennato all'importanza del
grande logico e filosofo della matematica
Gottlob Frege (1848-1925).
Gli interessi filosofici di Frege (e le opere che ha scritto) erano rivolti soprattutto
alla logica ed alla filosofia della matematica, ma un suo breve articolo del 1892,
Über Sinn und Bedeutung (in "Zeitschrift für Philosophie
und Philosophische Kritik" C (1892) 25-50; la più accreditata traduzione italiana è
Senso e denotazione, in La struttura logica del linguaggio, a cura di
Andrea Bonomi, Milano, Bompiani, 1995 [1973], pp. 9-32) è una pietra miliare anche
per la linguistica. Dal SUO punto di vista, probabilmente,
questo intervento non rappresentava molto più di uno sconfinamento occasionale nelle
lingue naturali e nella loro logica, ma per NOI è assolutamente fondamentale,
in quanto è alla base (anzi, ne segna in realtà la nascita) di tutta la moderna
tradizione filosofica analitica, logica e filosofia del linguaggio compresa,
ed in particolare di quell'area di studi che si suole indicare come "semantica"
(ossia lo studio del significato). Noi ne daremo, naturalmente,
un resoconto estremamente semplificato e limitato ai pochi punti che più ci riguardano
in quanto linguisti, ma di questa originaria e costituzionale differenza
di interessi dobbiamo comunque sempre tener conto per interpretare correttamente il
pensiero di Frege, e rapportarlo alla tradizione linguistica.
Ma prima di entrare direttamente nella teoria semantica del 1892, ci
conviene prenderla più da lontano, e precisamente dal principio di composizionalità,
che ha le sue naturali premesse nel De interpretatione
di Aristotele (i cui capitoli iniziali vi invito a rileggere), e da cui abbiamo
preso le mosse noi, e da alcune riflessioni metodologiche in genere
(da cui ha preso le mosse Frege per la sua semantica), così come nascono nei
Fondamenti dell'aritmetica del 1884 (Die Grundlagen der Arithmetik. Eine
logischmathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl [I fondamenti
dell'aritmetica. Una ricerca logico-matematica sul concetto di numero], Breslau,
Koebner, 1884; trad. it. in Logica e aritmetica, a cura di C. Mangione,
Torino, Boringhieri, 1965).
Il punto di partenza è il concetto di numero, il cui problema viene riformulato
linguisticamente: ossia la domanda (di filosofia della matematica) sui numeri "che cosa è un numero?"
diventa una domanda (di semiotica) sui segni dei numeri "a che cosa si riferisce il segno
uno?". «La non rappresentabilità del contenuto di una parola [ad es. del
numero "uno"], non è una ragione per negarle ogni riferimento [Bedeutung
'significato'], o per escluderla dall'uso. L'apparenza del contrario è dovuta al
fatto che noi consideriamo le parole in isolamento, ci domandiamo qual'è il loro
riferimento e lo cerchiamo in una rappresentazione. Così, una parola per la quale
ci manca un'immagine interiore corrispondente [non abbiamo, nell'es. prec. una
immagine mentale di "uno"] sembra priva di contenuto. Ma bisogna sempre considerare
un'intera proposizione. Solo in essa le parole hanno effettivamente un riferimento»
(Frege, Fondamenti, cit.). In altre parole, un segno ha davvero significato
solo nel suo contesto, ed, e converso, una proposizione significa in quanto
è la sommatoria dei segni che la compongono. E questo ha valore, come noterete,
pienamente linguistico oltre che matematico, getta ossia le basi di una teoria
semantica, ed è per questo che è per noi così importante.
La semantica (ossia la teoria linguistica del significato) di cui
i Fondamenti dell'aritmetica avevano gettato le basi semiotiche, sarà finalmente
abbozzata nel 1892 in Über Sinn und Bedeutung; dico, naturalmente, solo abbozzata
perché (l'ho già detto, ma giova insisterci) a Frege importava più una teoria sulla
matematica che non sui linguaggi naturali.
Ora, se è vero che solo nella preposizione le parole trovano veramente
il loro significato, come avevamo scoperto nei Fondamenti dell'aritmetica,
dobbiamo pur sempre interrogarci sulla natura dei segni di base, ossia, in
sostanza, tracciare le linee maestre della semiotica di Frege.
In generale, per Frege ad ogni «segno [Zeichen] (sia esso un nome, una connessione
di parole, una semplice lettera) è collegato, oltre a ciò che è designato, e che
potrei chiamare la denotazione [Bedeutung 'significato'] del segno, anche
ciò che chiamerei il senso [Sinn 'senso'] del segno, e che contiene il modo
in cui l'oggetto viene dato» (Frege, trad. cit. p. 10; per semplificare, comunque,
ci limiteremo solo ai nomi che siano «la designazione di un singolo oggetto», ossia
dei "nomi propri"). Il "significato" (Bedeutung) di un nome proprio è pertanto il
suo riferimento, cioè «è l'oggetto stesso che con esso degniamo» (ibid. p. 13);
il "senso" (Sinn) è la parola medesima, «la designazione di un singolo oggetto»
(ibid. p. 10). Inoltre, ad una Bedeutung possono anche corrispondere
più Sinne: ad esempio il pianeta Venere (Bedeutung) può essere designato
tanto "Espero" quanto "Vespero" (con due Sinne diversi, dunque); e sono,
come Frege ben sa, proprio le lingue naturali ad essere particolarmente complicate
sotto questo rispetto.
«Dalla denotazione [Bedeutung] e dal senso [Sinne] di un segno
[Zeichen] va tenuta distinta la rappresentazione [Darstellung]
connessa al segno», che è «un'immagine interna [...] spesso impreganta di sentimenti
[... e] non è sempre collegata al medesimo senso, neppure nella stessa persona.
La rappresentazione è soggettiva, varia da persona a persona» (ibid. p. 12).
L'esempio seguente dovrebbe contribuire a chiarire la concezione di Frege:
Per chiarire questi rapporti può forse essere utile il seguente paragone. Immaginiamo che qualcuno osservi la luna attraverso un cannocchiale. Ora, io paragono la luna alla denotazione; esso è l'oggetto di osservazione reso possibile dall'immagine reale proiettata dalla lente dell'obiettivo dentro il cannocchiale e dall'immagine retinica dell'osservatore. In questo paragone, l'immagine dell'obbiettivo è il senso, e l'immagine retinica è la rappresentazione o intuizione. L'immagine del cannocchiale è cioè solo parziale poiché dipende dal punto di osservazione, eppure è oggettiva, perché può servire a più osservatori. Si può predisporla in modo tale che più persone contemporaneamente possano utilizzarla; l'immagine retinica è invece tale che ognuno deve avere necessariamente la sua. Sarebbe perfino difficile ottenere una congruenza geometrica, per la diversa conformazione degli occhi; una effettiva coincidenza sarebbe comunque da escludersi. Si potrebbe ancora continuare ad usare questo paragone supponendo che l'immagine retinica di A possa essere resa visibile a B, oppure anche allo stesso A attraverso uno specchio. Si potrebbe allora forse mostrare come una rappresentazione possa essere assunta essa stessa come oggetto, ma che, in quanto tale, non è per l'osservatore ciò che invece è per chi se la rappresenta direttamente. Ma seguendo queste implicazioni ci allontaneremmo troppo dal nostro argomento.
[tav. 16]
L'esempio del "cannocchiale di Frege". Da Senso e denotazione, in La
struttura logica del linguaggio, a cura di Andrea Bonomi, Milano, Bompiani,
1995 [1973], p. 13.
A ben guardare, in realtà, l'impostazione di Frege e quella di Saussure
sono, da un punto di vista sostanziale, più simili di quello che non appaia a prima vista.
La principale differenza di fondo, infatti, è semplicemente il diverso grado di approfondimento di
una parte (segno linguistico in Saussure) rispetto ad un'altra (riferimento oggettuale
in Frege) della teoria semantica; e questo, va inoltre sottolineato, è più l'effetto
dei diversi interessi dei due studiosi (logica e matematica per Frege, lingue naturali
e linguistica per Saussure) che non di una divergenza teorica di fondo.
Le differenze più evidenti (e che più facilmente traggono in inganno) sono invece a livello
terminologico.
È questo, macroscopicamente, il caso delle due, fondamentali, coppie signifiant
et signifié in Saussure e Sinn und Bedeutung in Frege, che vogliono dire
cose completamente diverse (ed è questa la ragione per cui consiglio di mantenere
la terminologia in lingua originale onde non fare confusioni; la traduzione italiana
di Frege che ho citato cerca di aggirare il problema traducendo Bedeutung
con "denotazione" anziché 'significato', ma mi sembra ancora più semplice mantenere
il termine tedesco). In particolare, comunque, è soprattutto per "significato"
che Saussure e Frege intendono due concetti radicalmente diversi: nel primo il
signifié è una entità immateriale e psychique, mentale, nel secondo
la Bedeutung è un oggetto (la cui costituzione è un problema filosofico
da cui qui possiamo astrarre, ma che comunque non dipende in ultima analisi dall'uso
che facciamo del linguaggio). Invece il "senso", Sinn, di Frege, essendo l'espressione
con cui un'oggetto viene denotato, sembra corrispondere abbastanza bene in Saussure al segno
linguistico tutto (naturalmente non vogliamo con questo dire che i due concetti
siano del tutto uguali, ma solo capire che rivestono un ruolo tutto sommato analogo).
Inoltre, il "segno" di Frege (Zeichen) è tutt'altra cosa
dal signe di Saussure: laddove l'uno è materiale e concreto,
l'altro è immateriale e mentale. Lo Zeichen sembra invece assai prossimo alla
parole di Saussure, in quanto fregeanamente è "la faccia materiale di un senso", cioè
saussurianamente la "realizzazione materiale di un segno". Le "rappresentazioni"
di Frege sembrano, infine, quello che (in realtà non in Saussure ma nella tradizione
strutturalista postsaussuriana) per noi sono le "connotazioni".
Nella tavola seguente ho cercato di raffigurare le linee essenziali per un confronto
delle semiotiche di Frege e Saussure, evidenziandone la convergenza, al di là
delle diversità terminologiche che la nascondono:
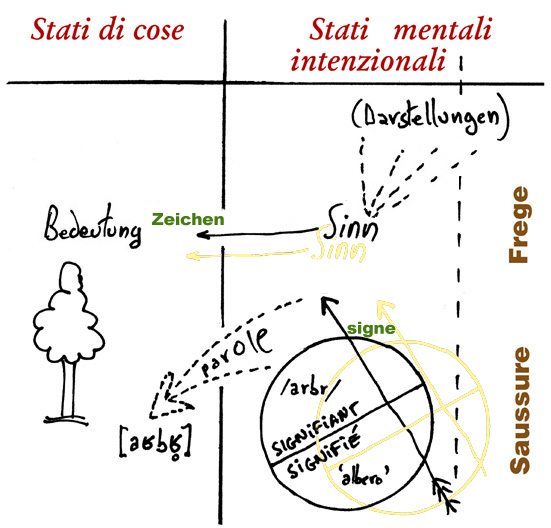
[tav. 17]
Una proposta di rappresentazione schematica dei rapporti tra le nozioni di Sinn
e Bedeutung di Frege e signifiant e signifié di Saussure.
Per quanto riguarda il principio della composizionalità e la semiotica
generale Saussure e Frege sembrano pertanto essere su posizioni (fatti salvi i diversi
interessi) abbastanza simili. Dove le due tradizioni divergono radicalmente è invece
sulla teoria del significato (inteso nel senso generale del termine).
Se per Frege, come abbiamo visto, il significato di un nome è il suo riferimento,
il significato di una proposizione è la sua verofalsità (idea che risale al
De interpretatione
di Aristotele, che vi invito a rileggere), cioè la sua proprietà di dire qualcosa di
vero o di falso sul mondo (naturalmente, Frege sa benissimo che esistono anche proposizioni
proposizioni che non vogliono dire nulla in quanto non sono o vere o false - ad
esempio "Werther è un personaggio di Goethe" è vera ma "Werther era alto un metro e
sessantasette" non è nè vera nè falsa perchè "Werther" non ha un referente nel mondo - , ma per i suoi scopi
queste non rivestono particolare interesse). Perché questa impostazione possa funzionare,
va aggiunto, bisogna che in qualche modo «l'umanità abbia un patrimonio comune
di pensieri che trasmette di generazione in generazione» (ibid. p. 12): si
parla di solito di un "platonismo" di Frege proprio per questa sua concezione che
l'umanità abbia un patrimonio comune di "idee", anche se poi precisare il senso
filosofico di questa posizione non è facile (e noi non lo faremo); comunque queste
"idee" da cui dipende la verità non sono di derivazione empirica od antropologica,
ma sono a priori presenti nella nostra mente.
In Saussure, ed ancor più nella tradizione filosofica che parte dal secondo Wittgenstein,
invece, cosa vuole dire una proposizione, non ha a che fare con la presenza di
alcun patrimonio di idee che ne permetta in assoluto la sua verofalsità, ma piuttosto
con gli usi che una comunità linguistica ne fa (e senza la quale nessuna verofalsità
potrebbe essere a priori stabilita): sapere cosa vuol dire seguire una regola
implica la presenza di una comunità al cui uso rimettersi.
Comunque, per riassumere, si configurano su questo aspetto due tradizioni distinte, che tuttora animano
il dibattito filosofico; da una parte una concezione antropologica per cui il
significato è funzione dell'uso, e dall'altra una posizione "platonica" per cui
il significato è funzione di una verofalsità possibile a priori, ossia insita nei
segni stessi che rimandano ad una realtà esterna indipendentemente dall'uso che ne fa
una comunità.
Abbiamo più volte detto che sia le parti discrete in cui si articolano
significante e significato, sia la funzione che li congiunge nel segno linguistico, sia la
composizionalità con cui più segni possono congiungersi agiscono sistematicamente.
Possiamo ora meglio comprendere come, per Saussure, una "langue" sia sempre un
sistema: ogni lingua (la "grammatica" di ogni lingua), ossia,
è un sistema coerente di funzioni, e come tale può essere analizzato e studiato.
Gran parte della linguistica del Novecento si pone infatti all'insegna dello
strutturalismo che nasce, appunto, dalla lezione di Saussure, rinforzata
anche dal modello della antropologia strutturale di
Lévi-Strauss.
Dire che la lingua è un "sistema coerente di funzioni" equivale
a dire, nella terminologia saussuriana, che «in uno stato di lingua tutto poggia
su rapporti» (Cours, p. 149 ed. it. = 170 ed. fr.); questi rapporti, nello
specifico, si snodano su due ordini di valori, l'asse paradigmatico (secondo
il termine introdotto da Jakobson e che si è oggi imposto come standard; Saussure
propriamente avrebbe detto associatif) e l'asse sintagmatico, che
riproducono il contrasto tra astratto e concreto dell'opposizione tra "langue" e "parole".
I rapporti sintagmatici sono
i rapporti, fondati sul carattere lineare degli atti linguistici, che i vari segni
(parole) intrattengono tra loro, schierandosi gli uni dopo gli altri, nella catena
della "parole": questi rapporti sono sempre in presentia, concreti, e sono
detti "sintagmatici" in quanto queste combinazioni sono chiamate "sintagmi".
I rapporti paradigmatici, invece, sono astratti e uniscono dei termini in absentia
in «una serie mnemonica virtuale", in altre parole sono strutture della "langue",
della grammatica di una lingua. L'esempio seguente di Saussure dovrebbe chiarire
meglio la questione; l'argomento è inoltre ben sviluppato nel manuale di Graffi -
Scalise (capitolo 2.5).
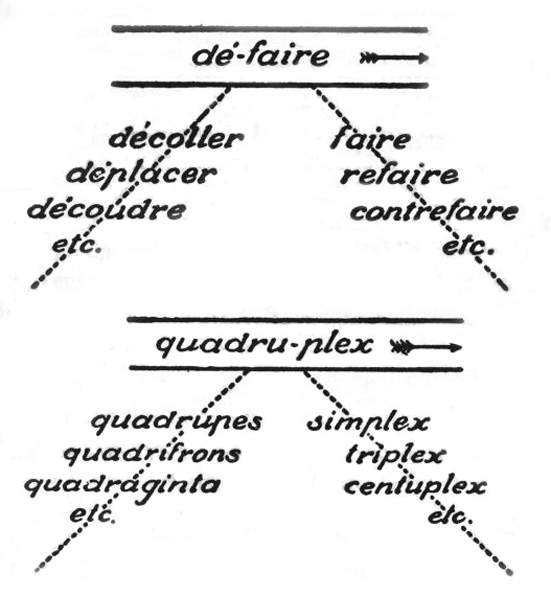
[tav. 18]
Riproduco l'immagine originaria del Cours, p. 178 ed. francese = 156 ed. italiana.
Che la dimensione associativa o sintagmatica sia a tutti gli effetti
presente nella langue, ossia il fatto che i segni linguistici siano "montati"
uno dopo l'altro secondo un tempo "mentale" nella langue "prima" ma allo stesso
modo in cui saranno scanditi nella parole, è cosa, a mio parere, evidente
a qualsiasi lettore non prevenuto del Cours. Bailly ha però sostenuto (in
importanti e soprattutto influenti) scritti propri che le regole della sintassi
(cioè quelle che presiedono alla disposizione dei segni sull'asse sintagmatico)
pertengono solo alla parole: la sintassi non farebbe così parte della langue. Il
che, a mio parere, è un assurdo, anche se quasi sempre ripetuto anche dai migliori
commentatori moderni: è, in altri termini, una tradizione interpretativa che, se pure dominante, è
sbagliata, ed il colpevole è Bailly.
Le conclusioni che abbiamo raggiunto nel paragrafo terzo, ossia che
la "langue" è una creazione storica ed antropologica ed è il risultato dell'uso del
linguaggio da parte di una determinata società di parlanti in un determinato momento
della storia, portano necessariamente a concludere che, anche se tutti gli uomini hanno
e probabilmente hanno sempre avuto la facoltà del linguaggio, le lingue (le "langues"
definite come sopra) sono necessariamente molteplici, variando a seconda dei gruppi
sociali che le esprimono, ma anche del tempo in cui sono state espresse.
Per Saussure, infatti, il tempo, oltre alla convenzione sociale, è l'altra coordinata
fondamentale per cui una lingua è quella che è: «en dehors de la durée, la réalité
linguistique n'est pas complète et aucune conclusion n'est pas possible» (Cours,
cit., p. 113). Lo schema, pertanto, che Saussure prospetta è il seguente:
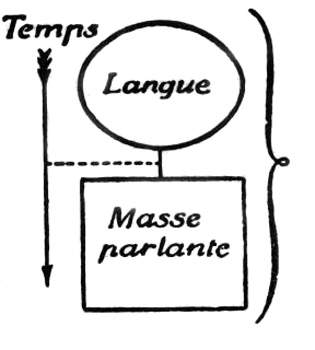
[tav. 19]
Tempo, società e linguaggio per Saussure. Riproduco l'immagine originaria del Cours,
p. 113 ed. francese.
Da questa constatazione discendono almeno due ordini di conseguenze,
che hanno variamente segnato la storia della linguistica successiva.
Il primo è dovuto al fatto che Saussure, od almeno Bailly per lui,
nel Cours dice espressamente che una "langue" è sempre un sistema ou
tout se tient. Questo, se preso alla lettera ed in assoluto ("i sistemi-langue
sono sempre perfettamente stabili e coerenti"), è in palese contraddizione con l'idea
del costante mutamento esercitato dal tempo (i sistemi cambiano continuamente, cioè
sono rinegoziati ad ogni atto di parole): se pensiamo alla comunicazione come
ad una attività criptata, in cui la langue sia la "chiave" crittografica,
la comunicazione perviene a buon fine se entrambi i partecipanti hanno la medesima
chiave; se questa gli cambiasse tra le mani nel corso della comunicazione medesima, il gioco
non funzionerebbe più. Ed allora: perché funziona? Due sono le risposte a questa
domanda.
La prima è non si debba pensare ai sistemi come organizzazioni perfette ou tout
se tient, ma come a strutturazioni sempre instabili, in cui a dei centri
relativamente coerenti si oppongono sempre delle periferie variamente destrutturate
od in ristrutturazione; pensate ai patchworks che presentano molte chiese antiche:
materiali di provenienza romana sono magari riutilizzati in una struttura complessivamente
barocca, ma con sopravvivenze di una cappella paleocristiana, un'abiside romanica,
una navata centrale gotica, un cupolone rinascimentale, fino alla ritinteggiatura
moderna: tutte risistemazioni, rimaneggiamenti, ristrutturazioni con una loro diacronia
che pur se hanno inciso sulla struttura dell'insieme, pure non ne hanno mai pregiudicato
la stabilità complessiva. Che le langue siano dei sistemi di questo tipo,
per definizione instabili, con centri e periferie che ne rispecchiano la complicata storia,
è quanto diceva espressamente Antoine Meillet (1866-1936), grande indoeuropeista
e linguista storico allievo di Saussure (alla École des Hautes Études, cui succederà
quando Saussure sarà chiamato al fatidico insegnamento universitario di Gibevra),
come lui attivo membro della Société de linguistique de Paris (di cui anzi diventerà
segretario), ma soprattutto amico e corrispondente stretto di Saussure, che ben
possiamo pensare come "persona informata dei fatti" ben prima che Saussure li svelasse
ai suoi allievi nel 1906. Ed il sospetto che Saussure lui même la pensasse
più come Meilett che come Bailly è forte.
La seconda è che il paragone con le chiavi crittografiche è troppo semplificante
e finisce per depistarci: la chiave delle lingue naturali è, a differenza
delle artificiali, fortemente ridondante: in ieri il mio gatto nero dormiva
il fatto che l'evento riferito si è svolto nel passato è detto due volte (l'avverbio
ieri ed il tempo imperfetto), che l'attore principale sia di genere maschile
quattro volte (il mio gatto nero) e di numero
singolare ben cinque (il mio gatto nero
andava); laddove in un linguaggio artificiale (come quello delle vere chiavi
crittografiche) ogni ridondanza è invece evitata. Questo garantisce la felicità
delle comunicazione anche in condizioni avverse, come appunto variazioni nel codice
(instabilità della langue) o perturbazioni del canale di trasmissione (per
una definizione formale di codice
e canale cfr.
il § 1.3.2 su Jakobson).
Il secondo ordine di conseguenze, questa volta esplicitamente
tematizzato nel Cours, è che Saussure introdotto il fattore tempo può
poi passare subito dopo a sostenere che possono pertanto esistere a pieno diritto
due tipi di linguistica, una sincronica (questo è il termine oggi usuale, Saussure
usava statique) ed una diacronica (évolutive). Tra le due linguistiche,
però, Saussure (che pure era un grandissimo linguista storico) sottolineava la
preminenza ideale della linguistica sincronica. Al momento di un atto locutivo,
infatti, tutti i rapporti paradigmatici che strutturano una langue sono comunque
sempre solo sincronici; l'aspetto diacronico si manifesta, invece, soprattutto
sull'asse sintagmatico, nella parole. Studiare la "grammatica" di una lingua
(la langue) è quindi eminentemente compito della linguistica sincronica.
La linguistica scientifica ottocentesca prima di Saussure, va detto, era sempre di norma stata
linguistica storica (la linguistica che noi oggi chiameremmo sincronica era quasi
esclusivamente legata a quello per noi sarebbe glottodidattica), e la asserzione di
Saussure sull'importanza della linguistica sincronica scientifica è stata
avvertita come rivoluzionaria, ed ha di fatto segnato profondamente lo sviluppo
della linguistica del Novecento.
Naturalmente, l'impostazione saussuriana che solo la sincronia, il momento del singolo
atto locutorio, era "reale" nella langue, è stata variamente riformulata e risolta
dagli strutturalisti successivi, in particolare da quelli che erano interessati a
edificare anche una linguistica storica strutturale, dopo la prima "sbornia" di
sincronia provocata dal Cours. Non possiamo qui menzionare tutti, e ci accontenteremo
di pochi cenni a due posizioni in qualche modo rappresentative.
La prima è quella assunta da André Martinet, il linguista francese che abbiamo già incontrato
a proposito della "doppia articolazione del linguaggio", che proponeva di cambiare
i termini del problema, pensando alla diacronia come ad una una sommatoria di infiniti istanti
sincronici, di fatto non isolabili se non astraendoli per comodità di studio, dato che nella realtà
sono sempre immersi nel fluire della diacronia. Con questo approccio (a volte detto "sincronia
nella diacronia") i capisaldi del pensiero saussuriano (il "sistema" e la sua struttura
sincronica) restavano comunque saldi, e si aprivano le porte a studiare il mutamento linguistico
in termini funzionalistici e strutturali (cfr. Economie des changements phonétiques. Traité
de phonologie diachronique, Bern, Francke, 1955, trad it. Economia dei mutamenti
fonetici. Trattato di fonologia diacronica, introduzione e traduzione di Giovanni
Caravaggi, Torino, Einaudi, 1968).
Una soluzione più radicale è invece quella avanzata in anni più recenti dalla teoria
della grammaticalizzazione, proposta da vari studiosi tra cui Elisabeth Traugott e Paul
Hopper (cfr. Approaches to Grammaticalization, 2 voll., edited by E. C. Traugott and
B. Heine, Amsterdam - Philadelphia, 1991): questa teoria riconosce realtà solo alla diacronia,
negando di fatto l'esistenza di una "langue" sincronica. Le conseguenze sono pesanti:
allora non si può più parlare di sistema (ma solo, semmai, di processi astratti e
tendenze evolutive generiche), e, di fatto, si dissolve lo strutturalismo in una
sorta di teleologismo (esistono solo processi) generale, senza reale supporto empirico
(se tutte le lingue evolvessero davvero in base alle medesime tendenze, ed in una unica
direzione, perché non avrebbero finito per diventare uguali?) ed epistemologico (la teoria
dell'evoluzione darwiniana aveva finalmente "liberato" l'evoluzione dal determinismo:
perché rischiare di reintrodurlo?).